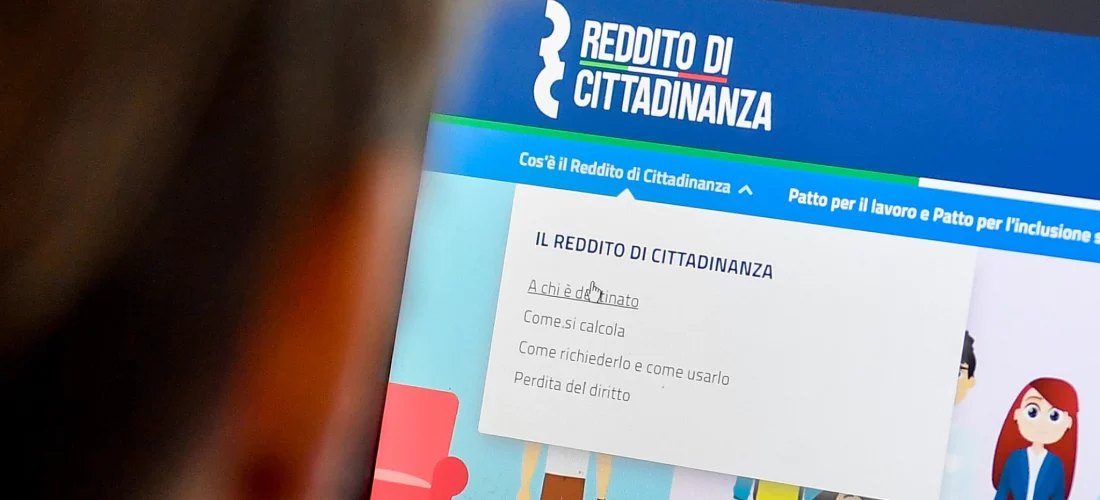«Reddito di base. La vera sfida al tempo della disoccupazione strutturale, del lavoro precario, flessibile, delocalizzato, immateriale è conservare il legame tra occupazione ed emancipazione».
Lo ius existentiae si pone alla base del contratto sociale. Sin dal ‘600 la coppia obbedienza-protezione s’è imposta come la fonte ultima di legittimazione del potere costituito. Spetta al “sovrano” difendere la vita dei consociati (Hobbes), ma anche i beni essenziali ad essa collegati (Locke). Se il potere costituito non è in grado di garantire le condizioni di “esistenza”, il popolo non è più tenuto a rispettare il pactum consociationis: il diritto di resistenza può essere esercitato.
Nella storia della modernità si è ritenuto che allo Stato dovesse spettare il compito di assicurare la pace (interna ed esterna), mentre il lavoro dovesse costituire il mezzo attraverso cui assicurare la “sopravvivenza” degli individui. La fine della civiltà del lavoro ha cambiato le carte in tavola. Oggi non basta più la volontà di lavorare, né quella di emigrare per poter sopravvivere. Come può lo Stato preservare il diritto all’esistenza?
In via di principio due sono le strade percorribili (tra loro non necessariamente alternative): lo Stato potrebbe assicurare comunque un diritto al lavoro, ampliando artificialmente l’offerta, incentivando – ad esempio – i lavori socialmente utili, anche se economicamente non necessari. L’altra via è quella di assicurare comunque un reddito di cittadinanza anche a chi – in assenza delle condizioni sociali che lo rendono possibile – non può lavorare.
In particolare, la prospettiva del reddito di cittadinanza ha un solido fondamento costituzionale. Essa ruota attorno a quattro principi che valgono a caratterizzare il nostro “patto sociale”: il principio di dignità, con il collegato dovere di solidarietà; il principio d’eguaglianza, inteso come modalità di realizzazione di una società di liberi ed eguali; il principio di cittadinanza, nella sua dimensione partecipativa e di garanzia di appartenenza ad una comunità; il principio del lavoro, assunto nella sua reale dimensione di vita, comprensivo del dramma del non lavoro.
È nel collegamento tra questi principi che si rinviene il diritto costituzionale ad un reddito di cittadinanza. L’errore cui si è spesso incorsi è stato quello di tenerli invece separati. Eppure nella nostra costituzione – più avanzata dei suoi interpreti – appare evidente l’intreccio. Si pensi al rapporto complesso che sussiste tra dignità e lavoro. Al lavoro è legata la dignità (il lavoratore ha, infatti, diritto ad una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»), ma è anche evidente come la “dignità” rappresenta un valore da assicurare in ogni caso, ponendosi (la “dignità umana”) come limite alla libertà di iniziativa economica privata, conformandosi come “dignità sociale” nel rapporto tra tutti i cittadini eguali davanti alla legge (nel combinato disposto tra gli articoli 36, 41 e 3).
Vero è che i nostri costituenti perseguivano l’obiettivo della piena occupazione, tant’è che alla Repubblica veniva assegnato il compito di «promuovere le condizioni» per rendere effettivo il diritto al lavoro. Dunque era questa la via maestra per dare dignità sociale ai cittadini. Se oggi però consideriamo non più perseguibile la prospettiva della piena occupazione l’unica alternativa per rimanere entro i confini tracciati dal costituente è quella di assicurare la dignità anche a chi non può lavorare. Non possiamo rassegnarci alle diseguaglianze di una società in cui sempre più ampie parti della popolazione vivono in grave disagio, non possiamo evitare di occuparci dei gruppi sociali in stato di emarginazione, non possiamo lasciare il mondo sempre più esteso dei non occupati senza speranza, privandoli di ogni dignità e opportunità di riscatto.
La lettura sistematica del testo costituzionale evidenzia anche un secondo dato, che a me sembra decisivo, ma che è invece assai sottovalutato nel dibattito attuale sul reddito di cittadinanza.
Detto in breve: nella nostra costituzione il diritto fondamentale alla sopravvivenza, i diritti alla vita dignitosa e all’assistenza come obbligo dello Stato, la lotta all’emarginazione sociale, non vengono assunti in sé, ma sono sempre collegati al necessario svolgimento della personalità, nonché definiti al fine di concorrere al «progresso spirituale e materiale della società» (come si esprime l’art. 4 in rapporto con il diritto al lavoro). Esplicito e diretto è poi il legame tra diritti fondamentali e doveri inderogabili (art. 2). Così come l’obbligazione generale di rimozione degli ostacoli d’ordine economico e sociale nei confronti dei cittadini è associato alla partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3).
È in questo complesso intreccio che deve trovare una sua specifica qualificazione anche il reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere inteso come reddito di partecipazione. Se si vuole cioè evitare che la sovvenzione ai non occupati si trasformi in un mero sussidio di povertà, caritatevolmente concesso ad un soggetto isolato, lasciato nel suo isolamento, e senza possibilità di riscatto, v’è una sola strada da perseguire: legare il reddito alla cittadinanza attiva. La vera sfida, al tempo della disoccupazione strutturale, ma anche del lavoro precario, flessibile, instabile, delocalizzato, immateriale, è quella di conservare quell’orizzonte emancipatorio, tanto individuale quanto sociale, che sin qui – nello schema fordista – era stato assicurato principalmente dal lavoro stabile entro una comunità solidale.
Ma come può legarsi il reddito alle attività sociali? E poi cosa si intende per cittadinanza attiva? Anche in questo caso si può cominciare a riflettere partendo dalla costituzione, la quale imputa a tutti i cittadini il dovere di svolgere un’attività o una funzioni che concorra «al progresso materiale o spirituale della società». Il riferimento è al lavoro tradizionalmente inteso, ma deve ricomprendere anche tutte quelle attività o funzioni che si svolgono “oltre il lavoro formale”. Il volontariato, l’assistenza ai figli o ai genitori, le attività culturali, quelle di natura immateriale, la cura dei beni comuni. Tutto ciò che – oltre la dimensione economica e immediatamente produttiva – permette agli individui di sviluppare la propria personalità e concorrere al progresso sociale.
Tutto ciò come si può realizzare in concreto? Se si guarda alle diverse forme di reddito proposte (universale, minimo, di disoccupazione) mi sembra che il più conforme al modello definito sia quello che assegna a tutti i bisognosi un reddito minimo, non tanto condizionato dalle logiche di workfare (che impone al titolare del reddito di accettare qualunque lavoro, anche il più degradante o incoerente con la propria formazione a pena della perdita di ogni contributo), quando costituito da due diverse fonti “reddituali”: una in denaro, l’altra definita da forme di sostegno indirette. In questo secondo caso il reddito consiste in garanzie di accesso gratuito ai servizi (scuole, università, consumi culturali, trasporti), ovvero al supporto al volontariato o all’associazionismo, ovvero ancora all’affidamento ai cittadini di strutture inutilizzate (dai teatri, alle fabbriche, ai centri sociali) per la gestione dei beni comuni. In questo caso il reddito di cittadinanza (inteso come servizi, agevolazioni e gestione degli spazi pubblici) potrebbe persino favorire la produzione di reddito da lavoro o configurare un’altra economia.
È questa una prospettiva che stenta a farsi strada e che pure non è assente in alcuni tra i progetti sul reddito (la proposta elaborata dal Basic Income Network, ripresa in sede parlamentare, alcune leggi regionali), persino in una risoluzione del Parlamento europeo del 2010. Per una volta possiamo dire: «ce lo chiede l’Europa».
Tratto da Il Manifesto 15 aprile 2015